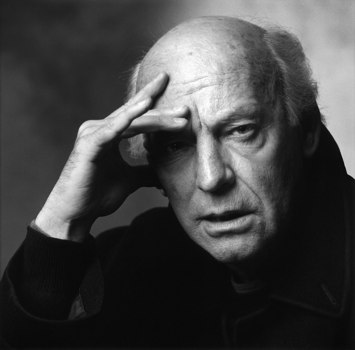Un sorriso di madre
Racconto di Carla Monaldi
Secondo premio sezione pubblica del Concorso letterario “In viaggio sulla via Francigena”

La povertà l’aveva sempre accompagnato nel viaggio della vita. In casa sua neanche le briciole di pane venivano sprecate, abiti e scarpe li riceveva dai fratelli più grandi, che non potevano più indossarli, scarpe che avevano percorso chilometri e chilometri di polvere, prima di essere risuolate svariate volte. Abiti rattoppati alle ginocchia, ai gomiti, ma puliti e profumati come solo sua madre sapeva trattarli, lì al lavatoio, con le altre donne del paese, quando trascorreva ore ed ore nell’acqua della vasca, a passare su e giù un misero pezzetto di sapone, a strofinare la stoffa consunta, mentre si scambiavano notizie e spettegolavano tra loro.
Era stato felice nell’infanzia, contentandosi di poco, correva nei prati e la sua fantasia volava trasportandolo in qualsiasi luogo gli venisse in mente, poteva essere un uccello dalle ali spiegate, un treno che sbuffava oppure un cavallo dalla lunga criniera. Ogni giorno dava una mano a suo padre con l’orto e la vigna. Quando era tempo di raccogliere le olive del principe Chigi, i bambini come lui, chini a terra, ne prendevano qualche manciata di quelle cadute, quelle che i fattori permettevano loro di tenere, sempre dopo che erano passate le pecore a ripulire. Ne racimolavano poche per ciascuno e una bottiglietta d’olio, da centellinare per le occasioni speciali, doveva bastare per tutto l’anno.
Ora, però, era tempi brutti, così cupi che la sua infanzia gli sembrava un periodo pieno d’abbondanza.
Qualche anno prima si era ritrovato con tanti sventurati giovani, come lui, nelle lande ghiacciate e desolate della Russia. Erano partiti in tanti, ignari di quello che avrebbero vissuto, marciando chilometri e chilometri sul bianco abbacinante. Ne aveva visti morire come mosche, lasciati lì, irrigiditi nel ghiaccio in attesa del disgelo. La fame era così abissale che li divorava da dentro. Il vento fischiava portando sferzate gelide di neve. Scavando nella terra, dura come acciaio, si poteva trovare soltanto qualche patata congelata, ma se si sapeva dove cercare.
Nelle baracche dove si erano riparati, il tepore del fuoco poco attenuava il gelo, ma bastava a risvegliare cimici e pidocchi, tormenti da aggiungere ai tormenti.
Fu uno dei pochi che era riuscito a tornare in patria. Le scarpe di cartone fatiscenti, dotazione del glorioso esercito, gli avevano causato un inizio di congelamento alle dita dei piedi e per quello, l’avevano rimpatriato. Lungo e rocambolesco il viaggio di ritorno su treni lenti e fatiscenti, col puzzo del fumo di carbone che entrava nel naso e nei polmoni. C’erano voluti mesi.
L’avevano, poi, spedito in Toscana, e da lì, la guerra l’aveva vista passare ma non più in prima linea. Udiva, ora, lo scrosciare dell’acqua dal rumore argentino, ipnotica, nel suo scorrere sempre uguale. Le cascate della Mola, il vecchio mulino medievale in rovina, era lì sulle rive del Crèmera che si nascondeva. Erano giorni che vagava scappando nelle campagne, tra viottoli sterrati e macchia mediterranea, all’ombra di querce secolari. Su quel suolo che in tempi remoti aveva visto annientare la famiglia dei Fabi, nella guerra contro l’antica città di Veio, ma lui, non poteva saperlo. La scuola l’aveva frequentata a singhiozzo, quella elementare, appena fuori porta, perché spesso doveva aiutare il padre nei campi. Fu così anche quella volta che avrebbe dovuto sostenere l’esame di licenza elementare, ma non poté andare, perché c’era da mietere il grano e la terra non aspetta i tuoi comodi, l’aveva apostrofato suo padre, ma la maestra, caparbia, glieli aveva fatti sostenere lo stesso, a sezione ormai chiusa, quando era potuto rientrare, perché era un ragazzo intelligente e non voleva che restasse senza titolo di studio.
Faceva un po’ freddo quella sera, era l’imbrunire di inizio settembre e una brezza leggera da ponente, portava l’umidità della notte. Non si azzardò ad accendere nessun fuoco, l’avrebbero individuato e la sua sorte sarebbe stata segnata. Aveva ancora addosso la divisa militare, non aveva trovato modo per disfarsene e non si fidava a bussare a nessuna casa. Erano giorni che vagava nei boschi, seguendo qualche piccolo tratto dell’antica Francigena, percorsa nei secoli dai pellegrini diretti a Roma. Era partito da Siena, aveva appreso la notizia in caserma, dove era scoppiato il caos e un fuggi, fuggi generale.
Nella notte avrebbe attraversato la valle del Sorbo, troppo aperta per farlo ora, con il lucore del sole che scendeva, piano, dietro l’orizzonte. Se tutto fosse stato calmo, avrebbe provato a bussare alla sua casa. Aveva mangiato more e prugne selvatiche, lì attorno ne era pieno, ma non sufficienti a placarne la fame. Si acquattò nel sottobosco e si strinse al petto la giacca sul corpo ossuto, poi, si addormentò. Sognò la Madonna del Santuario che gli sorrideva, sognò le scampagnate della Pasquetta formellese di martedì, con la famiglia, lì nella valle del Sorbo, la grande tovaglia a scacchi bianchi e rossi, gli stracci al sugo, preparati da sua madre. Al suo paese il periodo pasquale era più lungo, per via di quella diatriba millenaria con Campagnano, quando avevano perso il diritto di festeggiare il giorno dell’Angelo, proprio non potevano condividere l’evento.
Sognò lei, la ragazza dai riccioli rossi, dal viso sincero e serio, che era cresciuta senza madre, morta nell’ultimo parto, ancora giovane. Lei, che era dovuta crescere in fretta e furia, badando al padre e ai fratelli, quando ancora non arrivava neanche all’acquaio per lavare i piatti. Sognò di sposarla. Sognò i suoi cinque fratelli riuniti attorno alla tavola e sua madre che impastava il pane settimanale, le enormi pagnotte portate al forno del paese, il profumo che usciva dal comignolo. La fame lo svegliò, fu un miracolo, forse per quello la Madonna del Sorbo gli aveva sorriso. Lo sentiva il calpestio degli stivali che cercavano di non far rumore. Ma i rami si spezzavano sotto il peso del soldato tedesco. Fino a qualche giorno prima erano alleati che si guardavano in cagnesco, mal sopportandosi a vicenda, ma erano pur sempre dalla stessa parte, contro il nemico comune che voleva annientare l’impero.
Ora, per via di macchinazioni politiche, che a lui poco importavano, erano diventati nemici da combattere, e i nemici, alleati. Era proprio un mondo alla rovescia. Gli era toccato scappare come un topo braccato, con migliaia di altri sventurati soldati, ora allo sbando, che rubavano vestiti stesi ad asciugare, quando non ne trovavano in altro modo. Le divise erano un bersaglio su cui scaricare le mitragliette tedesche.
Il campanile di S. Lorenzo, in piazza, suonava la mezzanotte ma i rintocchi non arrivavarono nel bosco e lui cercava di rintracciare il tempo attraverso le ombre di luna.
Luna benevola nella semina dell’orto, gli aveva insegnato suo padre, ma ora maligna, perché lo metteva in pericolo, troppo piena, troppa luminosa, sembrava un faro che volesse indicare al crucco la sua presenza.
Tratteneva il fiato, fin quasi a farsi scoppiare i polmoni, non osava muovere un muscolo. Forse il soldato avrebbe proseguito nel bosco, qualcuno, però, lo aveva avvisato che lì, si nascondeva un traditore italiano.
Passò un cinghiale, e il soldato, voltandosi di scatto, sparò in direzione del rumore, nella tensione l’aveva scambiato per lui. Si udì il grufolare imbufalito della bestia, che non era stata colpita. La carica che ne seguì, il tedesco che correva fuggendo, mentre sparava all’impazzata senza vedere nulla. Accidenti, stavano venendo dalla sua parte e lui, se si fosse mosso, sarebbe morto.
Poi, la bestia, cambiò direzione scemando la sua carica infuriata, lontano.
Il crucco ansimava, piegato in due per la corsa, era a pochi passi. Lui cercò di aggirare il tronco della quercia dietro il quale si era nascosto. Fu in quel momento che l’altro lo vide; occhi negli occhi, sgranati e meravigliati di trovarselo davanti, quelli del tedesco. I suoi, bruni come la notte, fissi in quelle iridi chiare, trasparenti come l’acqua della cascata. Attendeva il colpo di grazia.
Erano faccia a faccia, l’altro, un ragazzino a cui a malapena era spuntata la barba. Alzò la mitraglietta, aveva trovato la sua preda. Lui mentre stava per perdere la vita, non pensò nulla, solo tremava dalla testa ai piedi, non avrebbe più rivisto la sua casa, a piazza Padella, ma almeno sarebbe morto sulla sua terra. L’avrebbero trovato lì, steso in un lago di sangue, con la divisa forata da decine di proiettili. Sua madre si sarebbe disperata al funerale, in una S. Lorenzo gelida per gli spifferi di un autunno incipiente, le sue sorelle l’avrebbero sorretta. La vedeva la scena, come dall’alto e pregò la Madonna che aveva sognato, affinché lo risparmiasse.
L’altro mise il dito sul grilletto, lo guardò negli occhi e per un istante che a lui sembrò lunghissimo, lesse in quello sguardo lo stesso suo smarrimento, la paura di non essere più al sicuro in una terra straniera, lontano da casa, dove c’era un’altra madre in attesa. I due in silenzio attesero ancora. Poi, il tedesco abbassò l’arma, finse non averlo visto, non disse una parola e proseguì tra le felci del sottobosco seguendo il corso del ruscello.
La Madonna aveva sorriso di nuovo.
[wl_navigator][wl_faceted_search]